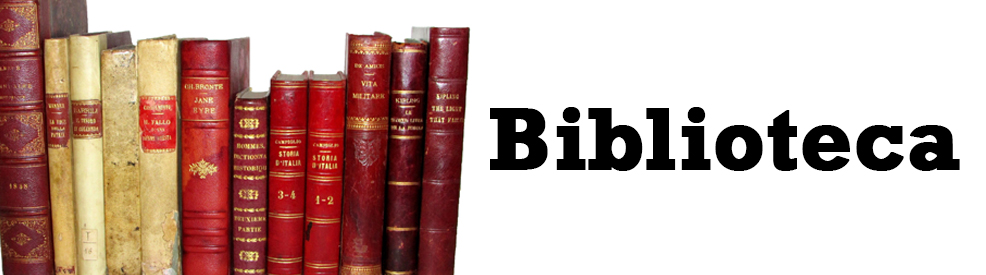SIC!: sport, parole e comunità contro ogni discriminazione
Il progetto Uisp si chiude con una ricerca, tre cicli formativi e un anno di attività nei territori per costruire ambienti sportivi più giusti e inclusivi“Ho visto più casi di discriminazione nei campionati giovanili che in quelli degli adulti”. La giovane arbitra lo dice con la naturalezza di chi non si stupisce più. Nella sua voce c’è poco risentimento, ma molta realtà. È una delle testimonianze raccolte da Davide Valeri, sociologo e autore della ricerca del progetto SIC! Sport, Integrazione, Coesione, promosso dalla Uisp con UNAR e Lega Serie A e sostenuto dal Dipartimento per lo Sport. Una frase che apre uno squarcio su ciò che accade davvero nello sport italiano: non nei grandi stadi, ma nei campi dove ragazze e ragazzi crescono, imparano linguaggi e definiscono cosa è accettabile e cosa no.
La ricerca di Valeri mette in fila un dato semplice e difficile da ignorare: le discriminazioni non sono casi isolati. Sono un sistema. Il razzismo, ad esempio, non si manifesta solo nei cori offensivi, ma nelle offese che non finiscono nel referto e in meccanismi normativi come lo ius sanguinis sportivo, che permette di tesserarsi ma non di sentirsi riconosciuti. Lo stesso vale per il sessismo, che si esprime nelle strutture di potere, nei budget, nei ruoli tecnici e soprattutto nelle narrazioni: le atlete occupano solo il 5% dello spazio mediatico e spesso non per parlare di sport. Oppure per l’abilismo, che non dipende dal corpo della persona ma dal modo in cui gli impianti vengono costruiti e dalle occasioni sportive che si creano per le persone che abitano quei corpi. O ancora per la condizione delle persone LGBTQI+, sottorappresentate e stigmatizzate negli ambienti sportivi, costrette a un imbarazzo che appartiene più a chi punta il dito che a loro.
Proprio per questo SIC! non ha lavorato solo sul “cosa” accade in campo, ma sul “come” viene raccontato. I tre workshop nazionali — dedicati alla nascita delle discriminazioni, alla disabilità, al razzismo e al sessismo — hanno rappresentato una delle eredità più concrete del progetto. Hanno permesso a operatori e operatrici dei comitati di interrogarsi su linguaggi, rappresentazioni, errori inconsapevoli e responsabilità di chi educa o dirige un contesto sportivo. La comunicazione non è stata trattata come un tema accessorio, ma come un’infrastruttura di giustizia: cambiare le parole significa cambiare gli spazi che quelle parole descrivono. Nella campagna di sensibilizzazione portata avanti da Uisp, a livello nazionale e territoriale, la collaborazione con Will Media, nata proprio in questo contesto con un video spot, ha permesso di amplificare questi messaggi, con un linguaggio più accessibile e più vicino alle culture giovanili.
Nel frattempo, nei territori, SIC! ha preso vita in forme diverse, coerenti con le storie e le necessità delle comunità sportive locali. A Firenze, tornei e attività che rivendicavano l’orgoglio LGBTQI+ hanno costruito spazi in cui la partecipazione non passava dal nascondersi, ma dal sentirsi parte di un contesto sicuro. A Genova, durante la Settimana del rifugiato, tornei multiculturali e momenti di racconto condivisi hanno messo in campo giovani del territorio, migranti e associazioni, in un ambiente in cui la relazione veniva prima della competizione. Anche la voce delle giocatrici del Genoa Women e la testimonianza di Junior Messias hanno avuto un ruolo importante nel rendere visibili le barriere che spesso rimangono sommerse.
A Como, l’iniziativa “Insieme per… fare canestro alle discriminazioni” ha portato sul parquet giovani atlete e atleti in un formato di gioco cooperativo, in cui “vincere” significava battere il canestro e non gli avversari. Un gesto semplice, ma capace di ribaltare simbolicamente l’idea stessa di competizione. A Venezia, il torneo “Un calcio al razzismo” ha coinvolto squadre giovanili in un lavoro che ha unito gioco e consapevolezza, mentre a Parma attività come “Beyond the border” o le iniziative di calcio inclusivo hanno costruito reti fra associazioni, tifoserie, giovani e famiglie. A Monza, il lavoro nelle scuole ha permesso di parlare con bambine e bambini di parole che feriscono e parole che includono, mostrando che l’educazione alla non discriminazione non è un tema per specialisti, ma una competenza che si costruisce fin da piccoli.
Queste attività non sono state gesti simbolici, ma risposte concrete ai temi emersi nella ricerca. Una delle voci più incisive è stata quella di Valeria Locritani, giovane atleta paralimpica intervenuta alla tavola rotonda finale del progetto. “Siamo tutti uguali nella nostra diversità - ha detto, raccontando come l’idea di disabilità derivi più dalle barriere che dalle persone - Ognuno ha le sue diverse abilità e il suo modo di fare le cose. Se guardiamo la diversità così, la concezione di “disabile” praticamente non esiste più”. Nel suo intervento, Locritani ha messo a fuoco uno dei punti centrale della ricerca: il problema non è la prestazione, ma l’ambiente. “Gli impianti accessibili sono quasi sempre quelli destinati all’agonismo. Ma chi vuole fare sport amatoriale spesso non può. Quando non puoi partecipare, non puoi mostrarti, e non puoi cambiare la prospettiva degli altri”, ha raccontato. L’abilismo, in questa lettura, non è un difetto individuale: è la conseguenza di un sistema che non prevede tutti i corpi.
La Settimana d’azione contro il razzismo ha reso visibile l’ampiezza di questo lavoro. Tornei multiculturali, attività nelle scuole, incontri con rifugiati, laboratori sul linguaggio e iniziative con giovani e associazioni sono stati raccontati attraverso una comunicazione coordinata che ha permesso al progetto di parlare con una voce sola. Foto, video, interviste e materiali condivisi dai comitati — amplificati anche dal lavoro nazionale — hanno trasformato quell’esperienza in un racconto pubblico collettivo.
L’appuntamento di San Benedetto del Tronto, il 25 settembre, ha chiuso questo percorso con una restituzione che non era solo un evento, ma un modo di riconoscere la complessità del lavoro svolto. Nella tavola rotonda “Pregiudizi in fuorigioco”, dirigenti, atleti, studiosi, rappresentanti istituzionali hanno ripercorso i punti chiave emersi nel progetto: l’urgenza di riconoscere le discriminazioni come struttura; la necessità di un cambiamento nei linguaggi; il ruolo del safeguarding per proteggere chi pratica sport; la centralità dei territori. La cornice, quella delle finali di di Matti per il Calcio che si sarebbero disputate poche ore dopo nello stesso luogo, ha dato a quel momento una forma simbolica: lo sport non come decorazione della vita sociale, ma come parte della cura delle comunità.
SIC! chiude il suo percorso lasciando strumenti, pratiche e consapevolezze. Lascia un vocabolario condiviso, tre cicli formativi che rimarranno patrimonio dei comitati, una rete di relazioni costruite nei territori, una ricerca che permette di leggere con chiarezza ciò che spesso resta non detto. Lascia soprattutto un principio: le discriminazioni non si contrastano con gli eventi, ma con gli ambienti. Come ricorda Valeri, “l’inclusione non nasce dagli eventi, nasce dagli ecosistemi”. È in quegli ecosistemi — nei campi, negli spogliatoi, nelle parole che scegliamo e nei gesti che facciamo — che il progetto continua, anche dopo la sua conclusione formale. (A cura di Lorenzo Boffa)
NOTIZIE DA UISP NAZIONALE